Moll Flanders (Collins Classics)
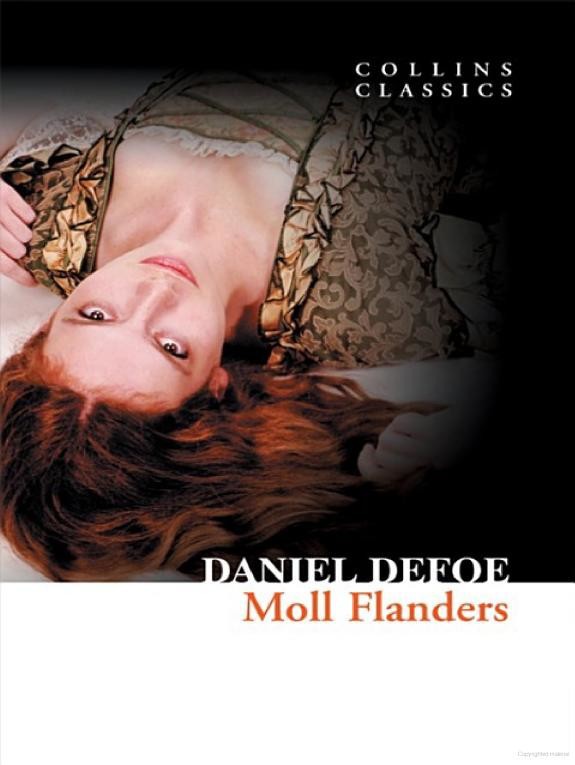
Daniel Defoe
Moll Flanders
I
Il mio vero nome è fin troppo noto, nelle carte e nelle cronache della prigione di Newgate e al tribunale dell’Old Bailey, e vi sono ancora pendenti faccende di gravità tale, riguardo alla mia specifica condotta, da far escludere che io possa firmare quest’opera o nominare la mia famiglia. Magari dopo la mia morte se ne saprà di più. Per il momento, però, non è il caso, nemmeno se viene un’amnistia generale, nemmeno se quell’amnistia riguarda chiunque e comprende tutti i delitti possibili.
Siccome i peggiori dei miei amici, che ormai non hanno più modo di farmi danno (perché sono usciti dal mondo via scaletta e corda, come tante volte stava per toccare a me), mi conoscevano col nome di Moll Flanders, che io mi presenti con questo nome a voi può bastare, e potete consentirmelo a patto che io abbia il coraggio di confessarmi tale e quale fui, e quale sono adesso.
Mi hanno detto che in una nazione vicina, non so se in Francia o dove, c’è un ordine del re per cui se un delinquente, quando è condannato a morte o alla galera a vita o alla deportazione, lascia dei bambini, questi, siccome generalmente mancano di tutto per la miseria o la confisca degli averi dei genitori, sono subito affidati alle cure del governo e messi in un ospedale che si chiama Casa degli Orfani, dove li crescono, li vestono, gli danno da mangiare, gli insegnano, e quando sono in grado di uscire li mettono in un mestiere o in un servizio perché possano provvedere a se stessi conducendo una vita onesta e laboriosa.
Fosse stato questo l’uso in Inghilterra, io non sarei rimasta da ragazza povera e derelitta, senza amici, senza panni, senza aiuto né protezione al mondo, come invece fu la sorte mia; per la qual sorte io mi trovai non solo esposta ad afflizioni grandissime, prima ancora di poter comprendere i casi miei e sapervi porre rimedio, ma anche avviata ad una vita di scandalo, che di norma conduce alla precipitosa rovina dell’anima e del fisico.
Ma da noi le cose stavano altrimenti. Mia madre fu condannata a morte come delinquente pericolosa per una sciocchezza di furto di cui non vale la pena di parlare, ossia aver colto l’occasione di prendere in prestito tre pezze di tela d’Olanda fine da un mercante di Cheapside. Le circostanze sarebbe un po’ lungo riferirle, e a me la raccontarono in tante maniere, così diverse fra loro, che quasi non saprei dire con sicurezza quale storia è quella giusta.
Sta di fatto comunque, e su questo punto sono tutti d’accordo, che mia madre fece il ricorso per gravidanza, e siccome la trovarono con tanto di bambino dentro ebbe una proroga di sette mesi circa; passato quel tempo, che impiegò per mettere al mondo me e restare incinta un’altra volta, fu richiamata, come si dice, alla condanna di prima, ma ottenne la grazia di essere deportata alle piantagioni, e abbandonò me che avevo sei mesi. Quel che è certo è che mi abbandonò in pessime mani.
Tutto ciò è troppo prossimo alle prime ore della mia vita perché io possa raccontare qualcosa di me stessa se non per sentito dire; basti ricordare che, nata in un luogo tanto infelice, non ebbi nella mia infanzia nessuna parrocchia alla quale rivolgermi per chiedere nutrimento. Non posso nemmeno spiegare come fui tenuta in vita. So soltanto che una parente di mia madre, mi hanno detto, mi prese con lei per qualche tempo e mi fece da balia, ma chi pagasse o chi avesse così deciso io proprio non lo so.
La prima cosa di me che ricordo, o la prima che ho saputo, fu che vagabondavo con una banda di quelli che la gente chiama zingari, o egiziani; ma dovevo stare con loro solo da poco tempo, credo, perché non mi avevano fatto né decolorare né annerire la pelle, come usano fare da piccolissimi ai bambini che portano in giro; e non so nemmeno dire come capitai in mezzo a loro, né come ne venni via.
Fu a Colchester, nell’Essex, che quella gente mi abbandonò. Ho in mente un’idea vaga d’essere stata io ad abbandonare loro (cioè, d’essermi nascosta e di non aver più voluto proseguire con loro) ma su questo fatto non so dare particolari; ricordo soltanto che, raccolta da chissà quale personaggio della parrocchia di Colchester, io raccontai che ero arrivata in quella città con gli zingari ma non avevo voluto proseguire con loro, e così mi avevano abbandonato, ma dov’erano andati io non lo sapevo, né potevano pretendere che lo sapessi. Mandarono, infatti, a cercarli per le campagne, ma non riuscirono a trovarli, pare.
Ora ero in condizione per cui c’era chi pensava a me; infatti, benché nessuno in città avesse per legge il dovere parrocchiale di mantenermi, tuttavia, quando si seppe la mia storia, e che io ero troppo piccola per qualunque lavoro, perché non avevo nemmeno tre anni, la pietà spinse i magistrati della città a ordinare che qualcuno si prendesse cura di me, e io diventai dei loro, proprio come se fossi nata lì.
Nella cura che mi assegnarono fu mia gran fortuna esser data, come si dice, a balia a una donna che allora era povera ma aveva vissuto in condizioni migliori, e ricavava da vivere pigliando con sé quelli che erano in situazioni come la mia e mantenendoli finché raggiungevano l’età in cui potevano verosimilmente andare a servizio o guadagnarsi il pane.
Quella donna aveva anche una piccola scuola, che teneva per insegnare ai bambini a leggere e a lavorare; e poiché, come già ho detto, era vissuta in altri tempi in un buon ambiente, tirava su i bambini a lei affidati non solo con ogni cura ma anche con molta arte.
Ma la cosa più importante era che la donna cresceva i bambini in modo molto religioso, perché lei era per bene, pia, donna di casa, amante della pulizia, piena di buone maniere, e sapeva vivere. Vitto scadente, alloggio miserabile e vestiti brutti: ma per il resto eravamo tirati su con maniere e garbo, come se quella fosse una scuola di ballo.
Mi tennero lì finché compii otto anni e appresi con terrore la notizia che i magistrati (così credo si dicesse) avevano stabilito che io andassi a servizio. Dovunque mi mandassero, io sarei stata capace di far ben pochi servizi, al massimo andare in giro per commissioni, o far la sguattera sotto una cuoca, e questo me l’avevano detto tante volte che la cosa mi metteva una gran paura; infatti, benché così piccola, io ero già assolutamente contraria all’idea di andare, come si diceva, a servizio (e cioè a far la serva). Alla donna che chiamavo balia dissi, perciò, che credevo di potermi guadagnare la vita senza servire, se lei era così buona da consentirmelo. Mi aveva, infatti, insegnato a lavorare con l’ago, la matassa e il fuso, che in quella città era il mestiere principale, e io le dicevo che, se mi teneva con sé, io potevo lavorare per lei, lavorare proprio forte.
Glielo dicevo ogni giorno, che volevo lavorare forte; e, alla fine, l’unica cosa che facevo era piangere tutto il giorno, e questo era un tale cruccio, per quella donna brava e buona, che incominciò a preoccuparsi per me, perché mi voleva proprio bene.
Così, un giorno, quando entrò nella stanza dove noi bambini poveri lavoravamo, si sedette di fronte a me, non al solito posto di signora maestra, ma come se avesse in mente di guardar proprio me, e vedere come lavoravo. Io stavo facendo qualcosa che m’aveva dato da fare lei; dovevo, mi ricordo, ricamare cifre su certe camicie che lei aveva avuto da fare; dopo un po’, lei si mise a parlare con me.
“O sciocca d’una bambina,” dice, “tu piangi sempre.” (Io infatti stavo piangendo.) “Da brava,” dice, “ma per che cosa piangi?”
“Perché mi porteranno via,” dico io, “e mi metteranno a servizio, e io non sono capace di fare i lavori di casa.”
“Senti, bambina,” dice lei, “anche se adesso i lavori di casa, come dici tu, non li sai fare, a poco a poco imparerai, e mica ti metteranno subito a fare le cose pesanti.”
“Sì, mi metteranno,” dico io, “e se io non le farò mi picchieranno, le cameriere mi picchieranno per farmi fare tutto il lavoro, e io sono soltanto una bambina piccola e non sono capace.” E qui mi rimisi a piangere, tanto che non riuscii più a parlare.
Questo commosse la brava balia, che era materna, e così decise che non sarei andata ancora a servizio; mi disse di non piangere, sarebbe andata lei a parlare col signor sindaco, e io a servizio non sarei andata finché non fossi stata più grande.
A me nemmeno quello bastò, perché per me era così terribile il pensiero di andare a servizio, che anche se lei mi avesse assicurato che non ci sarei andata finché non avessi compiuto vent’anni, per me sarebbe stato lo stesso; avrei seguitato, credo, a piangere fino a vent’anni, solo all’idea che un giorno dovessi finire a quel modo.
Quando la donna vide che non ero ancora tranquilla, cominciò ad arrabbiarsi con me. “E che vuoi di più?” dice, “non ti ho detto che non andrai a servizio finché non sarai più grande?”
“Sì,” dico io, “ma alla fine ci dovrò andare.”
“Che?” dice lei, “ma è pazza la bambina? Ma che vorresti essere… una signora?”
“Sì,” dico io, e mi rimisi a piangere così forte che un’altra volta mi mancò la voce.
La vecchia signora allora rise di me, come potete figurarvi. “Ma sicuro, madamina, sicuro,” dice, “vuoi fare la signora, tu. E si può sapere come farai a diventare una signora? Eh? Col lavoro dei tuoi ditini?”
“Sì,” dico io di nuovo, tutta innocente.
“Già, e quanto sei capace di guadagnare?” dice lei. “Quanto puoi prendere per il lavoro che fai?”
“Tre soldi se filo,” io dissi, “e quattro se faccio un lavoro completo.”
“O povera la mia gran signora,” disse lei ridendo, “e a che ti servirà?”
“A mantenermi,” dico io, “se voi mi tenete a vivere qui con voi.” Questo lo dissi con accento tanto pietoso e supplichevole che il cuore di quella povera donna, come lei mi disse poi, s’intenerì per me.
“Ma,” dice lei, “mica basterà per mantenerti e anche per comprarti i vestiti. E chi dovrà pagare i vestiti della signorina?” dice. E intanto continuava a sorridere guardandomi.
“Lavorerò molto di più,” dico io, “e vi prenderete tutto voi.”
“Povera bambina, non basterebbe a mantenerti,” lei dice, “basterebbe appena per darti da mangiare.”
“Allora farò a meno di mangiare,” dico io, sempre innocente, “ma lasciatemi star qui con voi.”
“Ah, sì? Tu puoi vivere senza mangiare?” dice lei.
“Sì,” dico ancora io, da quella bambina che ero, figuratevi, e di nuovo mi metto a piangere forte.
Io non avevo fatto nessun calcolo; capite bene che era solo istinto; ma si univa a tanta innocenza e a tanto calore che, alla fine, la brava donna dal cuore materno si mise a piangere anche lei, e piangeva forte come me, e poi mi prese e mi condusse fuori dalla stanza della scuola. “Vieni,” dice, “tu non andrai a servizio, tu resterai a vivere con me.” E quello, per il momento, mi calmò.
Qualche tempo dopo, un giorno che lei andò dal sindaco e parlò di cose che riguardavano il suo lavoro, saltò fuori anche la storia mia, e la mia buona balia raccontò al sindaco tutto il fatto. Al sindaco la storia piacque tanto che chiamò a sentirla anche la moglie e le due figlie, e la cosa li mise tutti, figuratevi, in allegria.
Sta di fatto che nemmeno una settimana era passata che si presentano in casa la signora sindachessa e le figlie a cercare della mia vecchia balia, a vedere la scuola e i bambini. Dopo aver dato un’occhiata in giro, “Allora, signora…,” dice la sindachessa alla mia balia, “si può sapere qual è la ragazzina che vuol fare la signora?”
Io la sentii, e a tutta prima mi spaventai moltissimo, senza sapere nemmeno perché; ma la signora sindachessa mi viene vicino. “Brava, signorina,” dice, “che lavoro stai facendo?”
La parola signorina era un’espressione che non s’era quasi mai udita nella nostra scuola, e io mi domandai chissà che brutta parola mi aveva detto. Però mi alzai, feci una riverenza, e lei mi prese di mano il lavoro, lo guardò e disse che andava benissimo; poi mi prese una mano tra le sue. “Chissà,” dice, “la bambina potrebbe anche fare la signora, per quel che ne sappiamo: ha una mano da signora,” dice.
Questo potete immaginare che mi fece un gran piacere; ma la signora sindachessa non si fermò lì e, messa una mano in tasca, tirò fuori uno scellino e me lo dette, mi raccomandò di badare al mio lavoro, e di imparare a lavorare bene, e disse che per quel che ne sapeva lei poteva darsi benissimo che io arrivassi a fare la signora.
Certo è che in quel momento né la mia buona balia né la signora sindachessa né gli altri capivano me; loro infatti con la parola signora intendevano una cosa, e io un’altra completamente diversa; per me, purtroppo, fare la signora significava avere un lavoro indipendente e un guadagno bastante per mantenermi da sola senza lo spauracchio terribile di andare a servizio, mentre per loro significava fare una vita bella, ricca, elevata e chissà che altro.
Quando se ne fu andata la signora sindachessa, entrarono le figlie, e anche loro chiesero della piccola signora, e mi parlarono per un po’, e io risposi con la mia aria innocente; ma sempre, quando mi chiedevano se ero proprio decisa a fare la signora, io rispondevo sì. Alla fine una di loro mi domandò che cos’è una signora. Questo mi mise in imbarazzo; però mi spiegai col contrario, dissi che una signora è una che non va a servizio e che non fa i lavori di casa. Loro si divertivano molto a farmi parlare, trovavano simpatica e gradevole, a quanto pare, la mia chiacchiera; e anche loro mi dettero del denaro.
Il denaro lo detti tutto alla mia balia e maestra, come la chiamavo, e le dissi che avrei dato a lei, come allora, tutto quel che avrei guadagnato quando sarei stata una signora. Da questo mio discorso e da altri, la mia vecchia istitutrice cominciò a capire che cosa intendevo io per fare la signora e che per me la cosa significava soltanto potersi guadagnare il pane col proprio lavoro; e alla fine mi chiese se era proprio così.